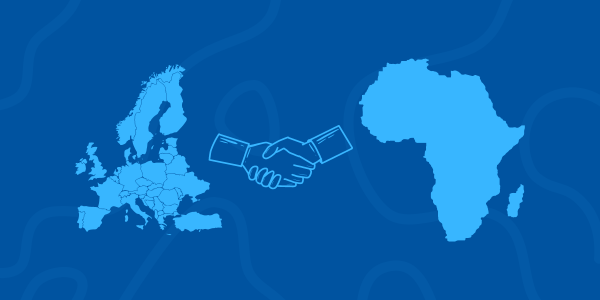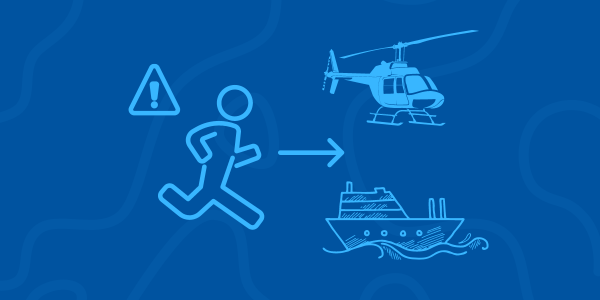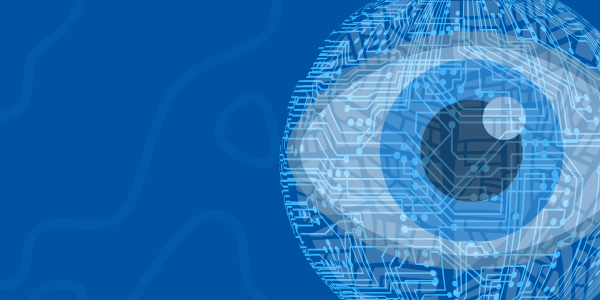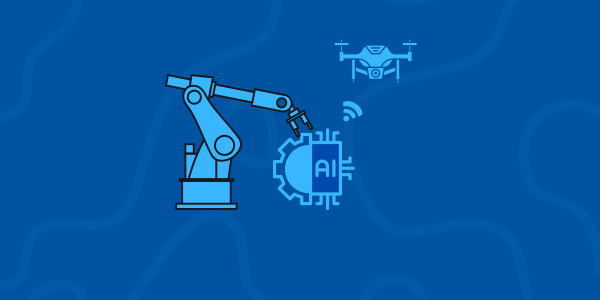Diplomazia e Forze Armate: un ossimoro?
INTRODUZIONE
Questo articolo presenta l’interazione fra la sfera civile e quella militare attraverso l’utilizzo di una lente di lettura forse inedita, ovvero l’azione poco conosciuta del Political Advisor (POLAD). Quando infatti si pensa alle Forze Armate, la politica di potenza è il primo pensiero che echeggia nelle nostre teste. Se è vero che, lo strumento militare puro è la caratteristica prima degli uomini e donne in divisa, questo si è con il tempo affiancato ad altri strumenti, come la diplomazia, che ne hanno allargato la portata incrementandone anche l’efficacia. Ecco che oggi l’ossimoro sembra sparire, ma è bene argomentarne le ragioni. Queste righe si pongono un duplice obiettivo: da un lato enfatizzare storia, ruolo e funzioni dei POLAD, dall’altro sottolineare come la dimensione politico- diplomatica abbia plasmato anche il nostro modello di sicurezza. Si può affermare infatti che progressivamente è emerso un “people-centered approach” dell’azione militare italiana aiutato da una forte componente di collaborazione civile-militare (CIMIC): è un dato di fatto, riscontrato nei teatri operativi e riconosciuto e apprezzato tanto dalle popolazioni locali quanto da Partner come la Svezia e il Regno Unito.
IL POLAD IERI E OGGI
É bene sottolineare come sul tema in oggetto sia presente poca letteratura, sebbene non manchino importanti punti di riferimento. Fra questi il manuale di Friedrik Wesslau “The political Adviser’s Handbook”, un valido ed accreditato punto di partenza, assieme al libro dell’Ambasciatore americano Robert Murphy “Diplomat among Warriors”. Murphy fu il primo a riconoscere, da un lato quanto la sfera civile e militare fossero distanti fra di loro, dall’altro la necessità di farle avvicinare sempre più. Egli parlava di “large areas of ignorance” fra le due sfere: comparto militare e quello civile funzionavano infatti a compartimenti stagni fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tramite il suo spiccato acume politico-diplomatico, egli fu in grado negli anni ’20 di mettere in guardia i suoi interlocutori a Washington sull’allora sconosciuto Adolf Hitler e poi durante l’ultima fase della Seconda Guerra Mondiale, in qualità di consigliere del Generale Eisenhower, cercò di porre l’attenzione degli Alleati sulle conseguenze politiche di un mancato supporto alla liberazione di Roma, sul crescente ruolo del Partito Comunista in Italia e sulla fallimentare divisione di Berlino in zone di occupazione all’interno dell’area sovietica. Robert Murphy fu un pioniere di un approccio che non voleva più solamente basarsi su mappe e posizioni strategiche, ma mirava a mettere al centro la dimensione politico-diplomatica e quindi l’impatto di ogni azione militare sulle popolazioni. Agendo “in punta dei piedi” egli ha sussurrato nelle orecchie di tanti militari del Dipartimento di Guerra prima e del DoD poi una visione di lungo periodo che ambiva a costruire la fiducia nelle popolazioni. Fu in pratica colui che scardinò il brocardo latino si vis pacem para bellum, modificandolo in si vis pacem para fidem.1
A distanza di molti decenni, il ruolo del POLAD si è ampliato e rafforzato e il lavoro di Wesslau ne è la testimonianza scritta. Oggi il POLAD mira a promuovere integrazione e sinergia, riunendo considerazioni diplomatico-politiche e di sicurezza militare per garantire che tutti i fattori e le vie di approccio siano presi in considerazione, suggerire linee d’azione nuove e contribuire con consigli e competenze all’esecuzione di operazioni militari, di intelligence e di attività antiterroristiche. Il suo apporto ha inaugurato una nuova concezione di diplomazia chiamata “Diplomazia trasformativa” ove l’accento è posto sulla “cucitura” tra la sfera diplomatica e quella militare, sulla quale i POLAD lavorano ogni giorno attraverso un delicato e paziente lavoro di tessitura. La loro opera si estrinseca lungo tre mansioni: analisi, rapporto e implementazione. Questo è anche il loro ordine di lavoro, che parte da un analisi del contesto operativo, si sviluppa e arricchisce attraverso il confronto e il rapporto diretto con la dimensione militare e culmina con azioni di negoziazione e diplomazia pubblica.
A questo punto è bene chiedersi: L’Italia è riuscita nella sfida di combinare la sfera politico- diplomatica con quella militare? La risposta a questo quesito non può che essere positiva. In aggiunta, lo ha fatto e continua a fare egregiamente. La scomparsa dell’URSS, la professionalizzazione degli eserciti, il ruolo dell’UE come soft power e la crescente multi- dimensionalità delle crisi nel mondo sono stati elementi che hanno accompagnato l’Italia verso un nuovo modello di difesa caratterizzato da una forte componente di cooperazione civile-militare. Roma ha deciso di diventare un “Security provider” non nell’ accezione tradizionale del termine (la pura politica di potenza sopra menzionata), ma seguendo il nuovo concetto della “Human Security” promosso dall’ONU, che vede la commistione fra aspetti militari, umanitari, politici e diplomatici della sicurezza. Dal 1982, con la ripresa della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, l’Italia ha inaugurato questo approccio in Libano. Gli Italiani si sono subito qualificati come “soldati di pace” guidati dal Generale Franco Angioni che attraverso la sua sensibilità e la sua ricerca di contatto umano con la popolazione libanese e palestinese ha aperto la via ad un modello italiano di peacekeeping. Per arricchire e consolidare questo metodo del quale l’Italia è leader, sono stati sviluppati sul Territorio nazionale rilevanti esempi di CIMIC, come l’omonimo gruppo multinazionale a guida italiana (MNCG), il CoESPU e il CASD. In altre parole, Roma salvaguardia la propria sicurezza nazionale attraverso una nuova “Italian Security culture” che riflette il continuo processo di osmosi fra mondo militare e mondo civile che ha “illuminato” e “arricchito culturalmente” l’approccio tradizionale alla sicurezza nazionale e internazionale, come sostenuto da diversi autori.
Se è vero che Roma ha optato per la “Human security”, dove maggiormente è stato possibile vederla all’opera? Quando questo approccio può essere messo in difficoltà? Due casi di studio sono particolarmente rilevanti per rispondere a queste domande: il caso Libanese degli anni ‘80 e quello Iracheno dei primi anni del nuovo millennio. Da un’analisi comparativa è chiaro come il contesto Libanese fosse di gran lunga più permissivo rispetto a quello iracheno, permettendo all’Italia di dispiegare a pieno il proprio potenziale. Non per questo a Baghdad si è ritornati al “military-driven approach”. Al contrario, nelle parole della Consigliera Ghivarelli, già POLAD del Comandante italiano della Missione NMI, ”Il senso del nostro impegno (..) non è assolutamente di combattimento ma di assistenza”. Un’assistenza che, condizioni di sicurezza permettendo, ha sempre cercato di favorire il dialogo e la cooperazione con la popolazione per lo “state and society building”. È questa l’anima della difesa italiana: Una naturale predisposizione al dialogo, alla comprensione, al rispetto delle culture altrui che fanno dell’Italia “un vero modello” come affermato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
CONCLUSIONI
Per concludere, quell’acume politico-diplomatico di Robert Murphy è oggi riscontrabile anche nei POLAD italiani. Questi hanno aiutato la dimensione militare a capire che è la popolazione il vero “key terrain” sul quale è necessario impegnarsi per ottenere duraturi risultati nel peacekeeping in aree di crisi. L’Italia è una media potenza non tanto e non solo per l’ampio ventaglio di impegni internazionali assunti, ma, come detto dal Segretario Generale ONU, anche per il suo centrale e unico ruolo di “Paese del nord, capace di comprendere le popolazioni del sud”, un ruolo saggiamente e brillantemente implementato sconfessando l’ossimorica contrapposizione fra diplomazia e forze armate.
Pubblicato il 23/03/2025
Nicola Marzotto (Dossier Difesa, Fondatore del Progetto)
BIBLIOGRAFIA
Ammendola, Teresa. “L’Esercito Italiano e Il Peacekeeping: Un Caso Di Incrementalismo Culturale.” Quaderni Di Sociologia, no. 32, Aug. 2003, pp. 37–62, https://doi.org/10.4000/qds.1181.
Boutros, Boutros-Ghali. An Agenda for Peace : Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace- Keeping : Report of the Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992. United Nations, 1992, https:// digitallibrary.un.org/record/145749.
Brunori, Giovanni Battista. “La Cooperazione Italia-Iraq.” TG2, 4 May 2023, https:// www.youtube.com/watch?v=oPFT9hdqxII.
Calculli, Marina. “National Prerogatives in Multilateral Peacekeeping: Italy in Lebanese Perception and Rome’s Role within UNIFIL II.” Cahiers de La Méditerranée, no. 88, June 2014, pp. 201–14, https://doi.org/10.4000/cdlm.7565.
Carati, Andrea, and Andrea Locatelli. “Cui Prodest? Italy’s Questionable Involvement in Multilateral Military Operations amid Ethical Concerns and National Interest.” International Peacekeeping, vol. 24, no. 1, 2017, pp. 86–107, https://doi.org/ 10.1080/13533312.2016.1229127.
Cladi, Lorenzo, and Andrea Locatelli. “Why Did Italy Contribute to UNIFIL II? An Analytical Eclectic Analysis.” Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, vol. 49, no. 1, 2019, pp. 85–97, https://doi.org/10.1017/ipo.2018.10.
Foradori, Paolo, and Paolo Rosa. “Italy. Hard Tests and Soft Responses.” National Security Cultures: Patterns of Global Governance, edited by Emil J. Kirchner and James Sperling, Routledge, 2010, pp. 66–85, https://www.researchgate.net/publication/ 283821355_National_security_cultures_patterns_of_global_governance.
Ghivarelli, Isa. Interview to the POLAD of the NMI Commander. 19 Apr. 2023.
Mattarella, Sergio. Intervento Del Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella in Occasione Della Festa Delle Forze Armate. Presidenza della Repubblica, 4 Nov. 2022, https:// www.quirinale.it/elementi/72844.
Murphy, Robert D. Diplomat among Warriors. Greenwood Press, 1976.
Wesslau, Fredrik. The Political Adviser’s Handbook. Edited by Lina Frödin, 1. ed, Folke Bernadotte Academy, 2013.
- l’Amb. Pasquale Ferrara nel suo libro “ Cercando un paese innocente” illustra questo cambio di paradigma utilizzando l’espressione “si vis pacem confirma fidem”. ↩︎